
FedericaCausero
L'esperienza di Federica, da Ravenna a Londra per trovare lavoro; ora lei si è affermata, ma la Patria è sempre la Patria: "e io ora cosa faccio?"
Tenendo in considerazione il numero di persone che negli ultimi anni hanno lasciato l’Italia per trasferirsi in Inghilterra, verrebbe da pensare che sia quasi facile lasciare tutto e partire. Voglio dire, l’han fatto in tanti, non può essere poi così difficile.
Per quale motivo non dovrei riuscirci io?
E così, un insieme di fattori quali la voglia di indipendenza, la noia della routine, la mia città nella quale ero vissuta per 23 anni che cominciava a starmi stretta, le idee poco chiare su ciò che veramente avrei voluto fare nella vita, ha fatto sì che all’inizio dell’anno 2014 lasciassi l’Italia per guadagnarmi un posto nella capitale inglese.

Federica Causero, Infermiera in Inghilterra.
Avrei potuto scegliere il percorso più facile, come la maggior parte delle persone dotate di buon senso hanno fatto dopo di me: ho una laurea in infermieristica, per cui sarebbe bastato rivolgersi ad una delle tante agenzie di recruitment che mi avrebbero assistito e guidato nel mio percorso, organizzandomi un colloquio, trovandomi un alloggio, fatto da tramite con i datori di lavoro; ma no, io ho voluto complicarmi la vita, decidendo di partire per Londra alla “sperindio”, senza avere un lavoro, né una casa, né un’idea di come si facesse a trovare un lavoro e una casa.
La verità è che inizialmente non la volevo neanche sfruttare la mia laurea. Normalmente una persona, una volta finita l’università, non aspetta altro che trovare un lavoro e sistemarsi. Io no. A me la prospettiva di una stabilità mi spaventava da morire. Non ero mai stata una di quelle che dicevano che un domani avrebbero voluto lasciare l’Italia, anzi.
Fino a quel momento la mia vita aveva seguito il corso naturale degli eventi: avevo sempre studiato, perseguendo l’obiettivo della laurea; ma una volta raggiunta quella?
Ero davvero sicura che l’infermieristica fosse la mia strada? Ero davvero pronta ad immaginarmi un futuro a Ravenna, con un lavoro le cui condizioni visti i tempi che correvano non sarebbero state di sicuro le più vantaggiose, magari in casa coi miei genitori perché chissà se sarei riuscita a comprarmi una casa mia? No, non lo ero. E tra tutti i posti ho scelto Londra, una città che non avevo mai visitato prima, ma che aveva sempre avuto un fascino particolare per me. Immaginavo me stessa camminare lungo Oxford Street con molteplici shopping-bag in una mano e una tazza take-away di Starbucks (quelle sulle quali il barista scrive il tuo nome) nell’altra. E con questa immagine in testa, acquistai su internet un biglietto di sola andata per Stansted Airport. Le difficoltà sono iniziate dal momento in cui ho messo piede sul territorio inglese: in aeroporto, non riuscivo a trovare il pullman che avrebbe dovuto portarmi in centro a Londra. E quando provai a chiedere informazioni, mi ritrovai per la prima volta a fronteggiare un problema che avevo sottovalutato: quello della lingua. Sì, perché a scuola io in inglese ero la prima della classe, che problemi avrei mai dovuto avere? Povera ingenua. Il pensiero che sorge automatico non appena una persona inglese ti parla nella sua lingua madre è: “E io ora come faccio?”.
Poi col passare del tempo ti rendi conto che, in qualche modo, fai. A distanza di più di due anni ancora mi stupisco di me stessa per esserci riuscita: io che non ero mai stata fuori da casa dei miei genitori, che avevo sempre avuto “la pappa pronta”, improvvisamente mi ritrovavo in un aeroporto straniero a dover cercare un pullman per raggiungere il centro di Londra. In qualche modo ci riuscii. E una volta in centro, mi ritrovai di fronte alla seconda difficoltà: la metropolitana. Mai stata prima in metropolitana. Per me quel groviglio di linee colorate stampato su quella cartina era paragonabile a un manoscritto in lingua araba.
E ancora una volta la domanda “E ora come faccio?” si ripete.
E di nuovo in qualche modo ce la si fa. Il mio primo alloggio a Londra è stato un ostello, più precisamente una camerata da dodici persone. Con il bagno in comune con tutti gli inquilini del piano. Il trauma nell’entrare in quella stanza e vedere quattro letti a castello tripli me lo ricorderò per sempre. Ma ero talmente stanca che avrei dormito in qualunque condizione, e inoltre, fa tutto parte del bagaglio di esperienza, mi ripetevo tra me e me. Nei giorni successivi, gli obiettivi sarebbero stati trovare un alloggio e, soprattutto, un lavoro. Perché senza lavoro lì non ci potevo rimanere, e io ci volevo proprio rimanere. Trovai un’agenzia italiana che affittava stanze, e riuscii a sistemarmi in una casa che alloggiava, oltre a me, altre nove persone. E per risparmiare decisi di dividere la stanza con un’altra ragazza. Anche questo fa parte dell’esperienza, mi dicevo. Cominciai a girare per bar e ristoranti con curriculum alla mano, e inizialmente la gente neanche mi capiva quando chiedevo se potevo lasciarglielo. Ed eccomi a fronteggiare la terza difficoltà: il numero di curriculum lasciati aumentava, e i riscontri positivi scarseggiavano. E l’illusione di arrivare a Londra e riuscire a sistemarmi subito andava pian piano scemando. Ho fatto prove in un paio di ristoranti, ho passato la selezione per lavorare al McDonald’s, ma mi ritrovai a chiedermi quanto fosse giusto, per me che avevo una laurea in infermieristica, e avevo la possibilità di sfruttarla, accontentarmi di altri tipi di lavori.
Un’amica infermiera con le idee sicuramente più chiare delle mie, era partita qualche mese prima di me per andare a lavorare in una casa di riposo in una città del nord dell’Inghilterra. Lei aveva fatto il colloquio dall’Italia tramite un’agenzia, che le aveva trovato anche l’alloggio, e mi ha detto che secondo lei avrei dovuto almeno provarci a cercare di lavorare come infermiera. L’idea un po’ mi spaventava: a parte il tirocinio, non avevo mai esercitato la professione neanche in Italia; sarebbe stata un’esperienza completamente nuova, in un Paese straniero, con una lingua che non era la mia. Ma di una cosa ero certa: io, per il momento, a Londra volevo rimanerci. Come ho già detto, normalmente gli infemieri italiani che decidono di andare all’estero si rivolgono alle agenzie di recruitment, le quali si occupano di organizzare il colloquio, di fare da tramite col datore di lavoro, e di fare da guida nel lungo processo che bisogna attraversare per ottenere il cosiddetto “Pin Number” (il codice che, in Regno Unito, ti permette di esercitare la professione infermieristica, come una sorta di iscrizione all’Albo). Ma io avevo scelto la strada più difficile, e ora mi trovavo a dover fare tutto da sola. Per prima cosa mi mobilitai per ottenere questo famoso Pin Number, rendendomi conto che il fatto che fossi in Inghilterra rendeva le cose nettamente più difficili, in quanto la maggior parte della documentazione necessaria per richiederlo era reperibile solo in Italia.
Non ringrazierò mai abbastanza i miei genitori per avermi sostenuto in questo, occupandosi praticamente di tutta la parte burocratica mentre io cominciavo a mettermi in contatto con agenzie del luogo per cercare di trovare un lavoro con il quale iniziare. Le offerte non tardarono ad arrivare. Ricordo ancora il mio primo “colloquio” telefonico (in Inghilterra solitamente prima del colloquio vero e proprio si usa sostenere una breve conversazione al telefono, per vedere se puoi essere all’altezza del ruolo che andrai a ricoprire): non potrò mai dimenticare quanto fosse “british” l’accento del mio interlocutore. In qualche modo riuscii a rispondere alle domande che mi poneva, e così mi guadagnai la possibilità di sostenere il colloquio vero e proprio.
La posizione che mi avevano offerto era per una casa di riposo, che si trovava non lontano dalla casa in cui abitavo.
Non avevo idea di cosa mi sarebbe aspettato, di quali domande mi avrebbero fatto, di quali risposte avrebbero voluto ascoltare da parte mia, e soprattutto: avrei capito quello che mi veniva domandato? Non ne ero sicura, ma ero decisa più che mai a provarci.
Il colloquio si svolse con la “matron” il livello più alto di infermiere in UK, in quel caso direttrice della casa di riposo), che si mostrò gentile e comprensibile sul fatto che il mio inglese fosse tutt’altro che perfetto. E ottenni il lavoro. Non avendo ancora il Pin Number, avrei dovuto iniziare come Health Care Assistant (l’equivalente dell’OSS in Italia), per poi passare a infermiera non appena mi sarebbe arrivato.
Ero felice.
Io, che ero “fuggita” non solo dall’Italia, ma anche da quella professione che non ero più certa dopo la laurea di voler esercitare, ora ero pronta per iniziare, più carica che mai. L’entusiasmo iniziale lasciò spazio all’angoscia non appena iniziai: il primo giorno di lavoro lo definirei “traumatico”, senza esagerare.
Mi sentivo un pesce fuor d’acqua.
Un pesce fuor d’acqua con una divisa fatta a vestito lungo fino a metà polpaccio a righine bianche e verdi. I colleghi erano per la maggior parte gentili, ma io mi sentivo continuamente d’intralcio, dovevo fronteggiarmi con persone che parlavano inglese con accenti provenienti da tutto il mondo partendo dall’Africa per arrivare alle Filippine, che usavano termini tecnici il cui significato mi era completamente ignoto. Era stancante, fisicamente e psicologicamente.
Avevo una casa e un lavoro, ma tutto si stava rivelando più difficile del previsto. Tante volte mi sono chiesta se ne valesse la pena, ma ho sempre stretto i denti e ho proseguito. E piano piano ti accorgi che non sei più tanto un pesce fuor d’acqua. Conosci la routine, i colleghi ti stimano, i pazienti e i loro familiari ti apprezzano. E gli sforzi sono in parte ripagati. Anche capire le persone ora non è più così complicato; ciò che all’inizio pareva essere impossibile, si stava verificando: riuscivo a sostenere una conversazione in lingua inglese.
La cosa più bella?
Sapere che la mia famiglia era orgogliosa di me. E tante volte, a causa dell’eccessiva pressione, avrei voluto mollare, ma qualcosa mi diceva che alla fine i miei sforzi sarebbero stati ripagati. Capii una cosa importante: al contrario di quanto accade in Italia, l’Inghilterra ti dà la possibilità di cambiare, qualora le condizioni in cui ti trovi al momento non fossero più adatte a te. E cominciai a prendere in considerazione l’idea di provare l’esperienza dell’ospedale pubblico, anche se non ero sicura che ne sarei stata all’altezza. Rimasi stupita nel vedere quante fossero le “vacancy” per il ruolo di infermiere nell’NHS (il sistema sanitario nazionale inglese), e cominciai a mandare qualche candidatura, seppur non fossi convinta al 100% di sentirmi pronta. Ma poi accadde la svolta: una e-mail, ricevuta da un’agenzia di recruitment, con su scritto che stavano cercando infermieri italiani per un ospedale oculistico nel centro di Londra, e che i colloqui di assunzione si sarebbero tenuti a Bologna.
Proprio ciò che cercavo.
Mi misi subito in contatto con la suddetta agenzia e mi accordai per fare il colloquio direttamente a Londra, mentre tutti quanti l’avrebbero sostenuto a Bologna. Stavolta non mi sentivo così insicura e sprovveduta come la volta precedente, il mio inglese era nettamente migliorato e lavorando in casa di riposo avevo potuto avere un’idea di come funzionasse la sanità inglese. E così passai il colloquio con successo e ottenni la posizione di Staff Nurse presso il Moorfields Eye Hospital di Londra. Era quindi arrivato il momento di dare la notizia in casa di riposo. Ammetto che la cosa mi preoccupava e non poco: non ero sicura che la mia manager l’avrebbe presa bene. E invece si mostrò dispiaciuta, ma soprattutto felice per me, augurandomi il meglio.
In Inghilterra quando lasci un lavoro organizzano addirittura una festa, il cosiddetto “leaving party”.
Trovo alquanto improbabile che in Italia un datore di lavoro reagirebbe allo stesso modo. In ogni caso, dopo un anno passato a Londra nel quale ero arrivata sprovvista di alloggio e lavoro, dopo aver trovato casa in periferia con altre 9 persone e un lavoro come health care assistant e poi come infermiera in casa di riposo, ora mi preparavo per passare le vacanze di Natale in Italia con la mia famiglia, e poi ritornare a Londra per iniziare la seconda fase della mia avventura, nella quale avrei già avuto un posto di lavoro, un alloggio in zona centrale fornita dall’ospedale (con addirittura il primo mese offerto da loro) e con un taxi che mi attendeva in aeroporto per portarmi all’accommodation.
Nonostante sia sempre difficile ritornare a Londra dopo le vacanze in Italia, stavolta sapevo che sarebbe stato più semplice, sentivo che finalmente, dopo un anno pieno di difficoltà e incertezze, avevo finalmente trovato una stabilità. Il fatto che l’ospedale mettesse a disposizione un alloggio per coloro che avevano sostenuto il colloquio per il Moorfields Eye Hospital è stato molto positivo, poiché in questo modo ho potuto conoscere quelli che sarebbero stati i miei futuri colleghi.
È impressionante quanto sia facile fare amicizia in queste situazioni: trovi persone che sono sulla tua stessa barca, stanno attraversando le tue stesse difficoltà, hanno i tuoi stessi dubbi e le tue paure, e hai la consapevolezza che affrontare il percorso insieme renderà le cose più semplici.
Per facilitarci ulteriormente le cose, l’ospedale ci ha organizzato un periodo di “induction” (una sorta di “benvenuto”, un’introduzione al ruolo) della durata di ben tre settimane, nelle quali oltre a conoscerci tra di noi abbiamo frequentato un corso intensivo sull’oftalmologia, in modo da poterci fare un’idea su ciò che ci avrebbe atteso una volta cominciato a lavorare.
Finita l’induction, siamo stati assegnati ai vari reparti. Per quanto mi riguarda, non avrei potuto sperare in un’accoglienza migliore: tutti quanti, dai manager ai colleghi, si sono mostrati fin da subito amichevoli e disponibili. E mi hanno fatto sentire parte del team, non ho mai avuto l’impressione di essere “la nuova arrivata”. E soprattutto, dopo un breve periodo di affiancamento, ero consapevole di quale fosse il mio ruolo in reparto, conoscevo perfettamente le mie competenze, e non mi sono mai sentita un “pesce fuor d’acqua”; questa è la differenza principale con il precedente lavoro: mentre in casa di riposo ero stata un po’ “buttata” a svolgere il mio mestiere, ed ero costretta ad impararlo mano a mano, ora nell’ospedale sapevo quel che dovevo fare, e avevo la sicurezza che nel caso in cui avessi avuto dei dubbi, ci sarebbe stato qualcuno pronto ad aiutarmi. Sembra una cosa scontata, ma non lo è, e fa veramente la differenza.
Essendo un ospedale interamente oculistico, i pazienti non sono in condizioni critiche, e ciò rende possibile un livello d’assistenza al paziente piuttosto alto, in quanto non ti trovi mai nella condizione in cui devi occuparti di talmente tante cose da non avere il tempo di respirare, come magari accade in un ospedale generale.
Ed è forse questa la parte del mio lavoro che mi piace di più, avere la possibilità di garantire ai miei pazienti il migliore livello di assistenza al quale possano aspirare. Dopo appena un anno di lavoro al Moorfields, mi è stata fatta la proposta di frequentare il Master per specializzarmi in oftalmologia, il tutto spesato dall’ospedale.
Questo per testimoniare quanto diano importanza alla formazione, sempre in collegamento al fatto di mantenere alto il livello assistenziale.
Penso sia molto importante provare a migliorare continuamente sé stessi affrontando nuove sfide, e per questo ho accettato la proposta di buon grado, anche se non posso dire di sentirmi sicurissima di potercela fare ad affrontare un master in lingua inglese; ma d’altra parte, all’inizio della mia avventura qui a Londra, non pensavo neanche che sarei stata in grado di lavorare come infermiera in Inghilterra.
Federica Causero, Infermiera in Inghilterra



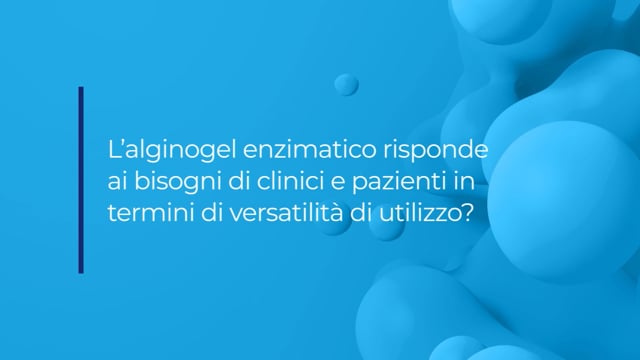














Commento (0)
Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?