Ho 32 anni e da 8 faccio l’infermiere
Non sarebbe forse il momento di garantire una dignità e un riconoscimento adeguato a questa professione?
Come per molti, la mia esperienza è nata in una RSA, dove ho iniziato a farmi “le ossa” con 40 ospiti dalle diverse situazioni socio-patologiche.
Lì dentro ho conosciuto i miei primi colleghi, uno dei quali mi disse una cosa che ancora oggi mi porto dentro e che quando posso cerco di trasmettere anche agli studenti, ovvero: prima di imparare cosa fare, impara come si lavora . Il modo di lavorare, inteso come atteggiamento, come gestire le cose, le persone e gli eventi, di qualsiasi natura essi siano.
Dopo poco più di due anni di RSA, essendo in graduatoria per un concorso, fui chiamato ed entrai in ospedale, prima passando da una medicina e gastroenterologia, poi approdando nel reparto di dialisi
Passati lì dentro cinque anni, ho fatto mobilità per cambiare sede lavorativa, lasciandomi alle spalle alcuni chilometri di troppo e una situazione lavorativa ormai tossica, per riabbracciare la mia medicina e tornare dopo pochi mesi nuovamente in dialisi, dove qualche mese fa ho compiuto il mio ottavo anniversario professionale.
La domanda è: possibile ne abbia già abbastanza?
All’attivo, come molti al posto mio, ho molti colleghi conosciuti, molti medici, molti pazienti, molti parenti, molti eventi più o meno stressanti, una pandemia e tanti problemi, tantissimi problemi interni di natura collaborativa, organizzativa e gestionale.
A mio modo di vedere credo che otto anni siano sufficienti per iniziare a farsi un’idea di come funzioni il mondo della sanità, sui suoi limiti e le sue criticità. Per come la sto vivendo io, un infermiere come tanti, sento di aver raggiunto una consapevolezza: quella di non sentirmi appartenere a un mondo che giorno dopo giorno vedo antiquato, obsoleto, fondato su principi probabilmente validi una cinquantina di anni fa ma che oggi, a seconda delle situazioni, fanno venire il voltastomaco.
Per far capire meglio, però, lo stato d’animo con cui più o meno tutti i giorni vado a lavorare, cercherò di descrivere le criticità che ai miei occhi sono le più pesanti nel quotidiano.
Per iniziare: quanti colleghi avrò visto e conosciuto in otto anni? Parecchi. Alcuni, nonostante distanze e sedi di lavoro diverse, li sento tutt’ora, perché sono persone dal cuore e dal talento unico con cui so di aver condiviso i momenti più belli; altri sono stati dei volti di passaggio, altri invece dei nemici con cui scontrarsi e litigare, per il diverso modo di pensiero, di metodologia di lavoro, di interpretare la professione.
Ci sono però diverse cose che accomunano tutti noi, dal collega migliore al peggiore, e che secondo me impediscono alla categoria di lottare per un fronte comune e per il futuro di una professione che sembra essere sempre più in difficoltà.
Prima cosa trasversale: il lamento costante . Sia esso per i turni, per l’organizzazione e i piani di lavoro, per il coordinatore, per il collega incapace/più bello/più sveglio/più capace, per lo stipendio, per le reperibilità, per le responsabilità e chi più ne ha più ne metta.
Durante lo scambio delle consegne all’orario di cambio turno ci sarà sempre un motivo per cui un collega abbia voglia di brontolare, per qualsiasi cosa quel giorno la mente gli dica di lamentarsi. Magari tu sei lì, a guardarti la punta delle scarpe sporca, spesso non partecipe a quella discussione che di certo non ti motiva a iniziare un turno lavorativo e a sorbirti gli ennesimi malcontenti di chi sai bene che quel lavoro sarebbe meglio lo cambiasse.
Ovunque, in qualsiasi ospedale, reparto di appartenenza e ultimamente anche età del professionista, il lamento, irrefrenabile e spesso afinalistico, sarà presente ad accompagnare i normali piani di lavoro quotidiani, come una cantilena a cui purtroppo ci siamo anche abituati.
L’immagine è quella di un branco di cani sciolti che ululano alla luna, magari anche per motivi validi, ma senza fare assolutamente niente per cambiare le cose se non continuare a lamentarsi. È troppo più semplice lasciare andare tutto così com’è, rendendo reale ciò per cui ci si sente impotenti.
Un lamento constante, fine a sé stesso , utile solo a guastare le acque di chi vi nuota dentro ogni giorno e ad avvelenare le menti anche dei più lucidi e volenterosi infermieri.
A rappresentare la professione, poi, vi è l’Ordine, che come ho avuto modo di osservare di recente, si palesa solamente quando c’è da concorrere per le elezioni dei nuovi rappresentanti, per ripiombare nel silenzio subito dopo le elezioni. In otto anni di lavoro, senza comunque averne mai avuto bisogno, non ho avuto la percezione di sentire un ordine vicino ai suoi iscritti , eccezion fatta ovviamente per le notifiche sulla retta annuale e sulle assemblee indette, che di certo sono tutt’altro che uno stimolo per la crescita e il futuro di una professione.
Ancora una volta la sensazione di essere un branco di pecore, rappresentate da un altro branco di pecore, che non fornisce nessuna spinta per muoversi in nessuna direzione, rimanendo lì, immobili ad osservare le cose senza un briciolo di interesse né di stimolo, fino a che non arriva l’ennesimo argomento utile per iniziare a lamentarsi.
In questo modo si innesca un circolo vizioso che spinge chi è nell’ambiente lavorativo a tirare i remi in barca
La questione pandemia, poi, ha di certo dato il colpo di grazia a molti, che per burnout o per illuminazione hanno abbandonato la nave. Non a caso ci sono state dimissioni in blocco e fughe mai registrate, con conseguente riduzione delle iscrizioni ai corsi di laurea reclutare professionisti provenienti dall’altra parte del mondo
Inoltre, sentendo la minaccia, il mondo esterno si accorse dell’esistenza degli infermieri e operatori sanitari, definendoli eroi, per dimenticarsene appena terminata l’emergenza e tornare a maltrattarli alla prima occasione disponibile.
In conclusione, calci e pugni - reali e metaforici - provenienti dall’interno e dall’esterno, a una categoria che mai si è tirata indietro di fronte a niente, in pandemia e in normalità, che ha sempre lavorato a testa bassa senza chiedere nulla in cambio.
Da persone umane, perché prima di tutto questo siamo, ci si rimane male, semplicemente e inevitabilmente e si perde progressivamente quella luminosità, quel buonumore, quella voglia che fino a quel momento ci ha portati lì, iniziando a chiedersi se non si meriti un futuro migliore, magari facendo qualcos’altro o facendo la stessa cosa altrove, lontano, dove forse il sistema funziona e lo senti dalla tua parte.
Veniamo poi alle questioni un po’ più materiali, vale a dire il riconoscimento economico rispetto al tempo speso in servizio e alle responsabilità che pesano sulle spalle. In quanto al tempo, con riposi saltati, reperibilità lavorate, straordinari, mezz’ore regalate per aiutare i colleghi, formazioni, riunioni, e chi più né ha più né metta, non è raro dire sono più tempo a lavorare che a casa mia .
In particolar modo, però, non dobbiamo dimenticare qual è lo scopo del nostro lavoro, cioè la promozione della vita delle persone, del loro stato di salute legato alle loro condizioni patologiche acute o croniche, mediando costantemente tra disposizioni mediche e malcontenti dei parenti.
In altre parole, lavoriamo sulla vita e sulla morte delle persone, sul loro benessere e sul loro malessere, con presenza e dedizione per garantire cure che soddisfino determinati livelli di assistenza.
Da questo penso si possa evincere che le responsabilità in gioco sono molto pesanti , che i rischi dovuti ad eventuali errori potrebbero essere enormemente elevati e metterebbero a repentaglio la libertà e l’integrità di un individuo.
Tirando le somme, sembra che dovremmo ricevere chissà quale stipendio, ma al contrario avrei piacere di capire perché percepiamo uno compenso che si discosta poco più o poco meno da un caporeparto di un supermercato, da un operaio di un’azienda metalmeccanica, da un consulente finanziario o un agente immobiliare (senza nulla togliere a ogni professione citata ovviamente).
Penso solo che, in base alle responsabilità, un professionista meriti un riconoscimento adeguato, perché anche questo gratifica le persone e i loro sforzi.
Soprattutto anche un bambino può notare che c’è differenza tra il garantire una via respiratoria pervia e mantenere uno scaffale in ordine, tra rimettere in piedi una persona dopo un intervento chirurgico e far firmare una RC Auto, tra garantire uno stile di vita adeguato a una persona in dialisi e la produzione di un pezzo in catena di montaggio.
Leggo che ogni poco ci battiamo per ricevere patetici aumenti di pochi spiccioli in fondo al mese, niente premi, tassazioni assurde e costanti, straordinari e festivi ultra-tassati e sottopagati, scatti di fascia che richiedono decadi prima di poterle richiedere.
Insomma, un insieme di circostanze che spingono un qualunque dipendente a valutare l’uscita dalla sua azienda per cercare maggiore fortuna e gratificazione altrove. Le pacche sulle spalle non interessano più a nessuno e oltremodo anche quelle scarseggiano come l’acqua nel deserto.
Qual è il senso di tutto questo?
L’acqua scorre inesorabile, le cose passano e cambiano. Da sempre mancano infermieri ovunque, ma adesso questi oltretutto fuggono e le università non hanno i numeri per colmare le lacune. Nessuno ci viene incontro, gli infermieri sono esausti, saturi di un sistema che non funziona, stanchi di chinare la testa aspettando la loro razione giornaliera di provviste che li fa sopravvivere invece di vivere.
Cosa dovrà succedere prima che il sistema imploda su sé stesso o il SSN collassi definitivamente? Credo sia arrivato il momento che le istituzioni la smettano di fare orecchie da mercante girando la testa dall’altra parte sminuendo o non prendendo minimamente in considerazione problemi che diventano via via sempre più insormontabili. Ne va del benessere di tutti.
In un futuro più o meno lontano a nessuno farebbe piacere recarsi al Pronto soccorso con un proprio caro che si sente male e non poter avere accesso alle cure perché la mancanza di personale lo impedisce. Eppure, è proprio lì che si sta dirigendo la sanità pubblica, verso una spremitura dei dipendenti che ne fanno parte, noncurante dello stress che gli causa, garantendo sempre meno efficienza in termini di cure e vedendosi sfuggire professionisti che non hanno la minima intenzione di barattare il loro tempo per pochi soldi e gratificazioni inesistenti in relazione alle responsabilità.
Sono stati abrogati i mansionari, è stato istituito un profilo, un percorso di studi strutturato, un codice deontologico, non sarebbe forse il momento di garantire una dignità e un riconoscimento adeguato a questa professione? Riflettiamoci, facciamolo tutti insieme, meritiamo di meglio.



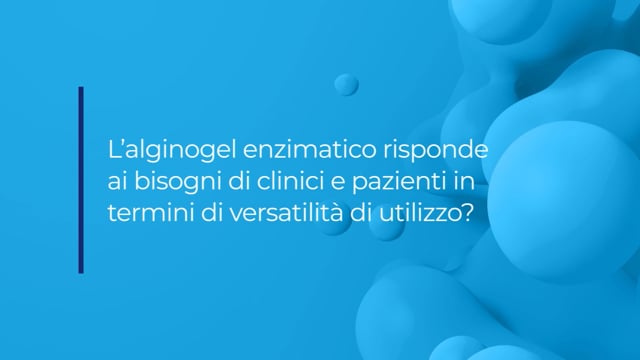
















Commento (0)
Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?