La storia di Olimpia studentessa di Infermieristica, che molla all’ultimo esame. Rimette in gioco tutto, ripensa agli anni passati, al tirocinio e decide di abbandonare. Prende un volo per l’Australia e rivoluziona la sua vita. Non “gioca” più a fare l’infermiera, ma la professione le manca e si sente in ogni riga della sua testimonianza.
Olimpia: Sapete essere infermieri è qualcosa di intimo, più intimo del sesso

Olimpia ha mollato all'ultimo esame, ma ora le manca fare l'infermiera
Mi chiamo Olimpia (nome di fantasia), sono ipersensibile ed iperemotiva, tendente agli attacchi di panico, creatività e scrittura. Amo i viaggi, la natura e la vita in ogni sua forma. Per tre anni ho meravigliosamente “giocato” all'infermiera tra cateteri, sacche di urina, macchie di sangue e gel igienizzante misti a immense soddisfazioni in tirocinio, anima e corpo. Per tre anni sono stata "QuellaSempreCarina&Sorridente", quella che i pazienti non vedono l'ora di rivedere, quella che agli esami accetta i 30 e i 18 con lo stesso entusiasmo, che quello che conta davvero è ben altro. Poi, in un momento in cui mi trovavo a combattere svariate battaglie personali, qualcosa è andato storto, qualcosa si è rotto. Il naso di mia nonna, per esempio.
Ore 3.27 am. Mi rigiro nel letto, sono agitata, mi sveglio con le grida di aiuto mia nonna. Corro nel suo appartamento, la trovo a terra in un lago di sangue che mi sconvolge. Si è soltanto rotta il naso (oltre che il collo), ma in quel momento resto quasi paralizzata. Poche ore dopo sono in aula per un esame piuttosto importante. So che voglio e devo farcela, sono vicina al traguardo, a un passo dalla laurea, ma la testa è da un'altra parte. Dopo un orale non particolarmente brillante, certo, ma sicuramente sufficiente, la professoressa mi appioppa un 21. Si prepari a studiare tutte le notti per il mio prossimo esame
, mi dice rabbiosa. La massacrerò. Al prossimo appello, io la massacrerò
. Non la prendo sul personale
, è la mia sola, pacata, risposta. Lei, spiazzata e furiosa, continua: Lei può anche andare in giro a raccontare a chi le pare quello che le ho detto, tanto qua ci siamo solo io e lei...questo per me non è nemmeno un lavoro, è un passatempo
.
Il fatidico appello arriva prima del previsto. Le dico tutto ciò che ricordo, ma mi blocco su un dettaglio. Lei mi guarda con aria truce. Mi punta gli occhi addosso con una cattiveria mai vista e sibila: Io non vorrei mai averla un'infermiera come lei. MAI. Nemmeno come collega. Manderei una lettera al caporeparto per essere spostata. Io un'infermiera così non la vorrei mai avere
.
Tra la delusione, la rabbia, la frustrazione e il male di quelle parole scoppio a piangere, mi alzo ed esco dall'aula. Al quarto inutile tentativo di liberarmi di quell'esame non ce l'ho fatta più. Non sto dicendo di aver abbandonato l’università per colpa di un esame, ma è innegabile, quello è stato il colpo di grazia che mi ha spinta a di mollare tutto e trasferirmi in Australia.
Non sopportavo più l'odore di urina, i pannoloni, le dentiere, qualsiasi forma di decadimento umano, fisico e mentale. Il deterioramento iniziava a terrorizzarmi. Ovvio, l'ospedale non è soltanto questo. Non è soltanto una palude di morte e dolore perenne e non è fatto nemmeno esclusivamente di gente che ha sbagliato mestiere o pazienti che hanno sbagliato pastiglia. È fatto anche di vite che nascono di nascite eutociche, ossa che si aggiustano, ferite che si cicatrizzano, famiglie che si ricompongono ed emorragie che si arrestano. Ma non ce la facevo più. Non riuscivo più a ridere. Il ruolo di “quella così carina sempre con il sorriso” non mi veniva più naturale. E me ne vergognavo.
Avevo un mare di cose per la testa, il che non era certo una novità, ma in quel momento era veramente troppo, o forse non abbastanza. Continuavo ad andarmene in giro giocando all’infermiera, continuavo a metterci anima e corpo e a dare incondizionato amore a chiunque incontrassi in reparto, ma stavo iniziando a cedere. Ne ero sicura. Sentivo il mare ritirarsi, come prima dell’arrivo di uno tsunami. Capitava che fossero i pazienti a cercare di consolare me. Che fossi io a riversare su di loro le mie paure, le mie fonti di tristezza e tutto il resto. E mi vergognavo anche di questo. Non sopportavo più i farmaci, le prescrizioni inutili, il dover somministrare medicinali in cui non credevo pienamente. Ho sempre cercato di farlo nel migliore dei modi, questo ci tengo a precisarlo, ma sono arrivata a un punto in cui mi sembrava di rivestire un ruolo che non mi apparteneva più completamente.
Stavo perdendo di vista l’obiettivo. Senza più lezioni da frequentare, con una bella tesi in mano e varie proposte di lavoro sia in Italia che all'estero, stavo per mandare all’aria gli ultimi tre anni della mia vita, oltre che tre anni di sacrifici, pianti, tasse universitarie versate dalle tasche dei miei genitori e traguardi duramente guadagnati. Stavo per salutare la porta d’accesso a un potenziale posto di lavoro fisso, pressoché assicurato e ben retribuito, al di là di qualsiasi critica al sistema. E tutto questo per cosa? Per un biglietto aereo di sola andata, un visto temporaneo e un futuro incerto e instabile nell’altro emisfero. Eppure sapevo che stavo facendo la cosa migliore che in quel momento potessi fare. Per la prima volta in vita mia mi sentivo realmente sulla strada giusta. Una strada decisamente sterrata, un po’ fuori mano e sconosciuta.
E così si parte. Impacchetto la mia vita in una ventina di chili più macchina fotografica e bagaglio a mano e faccio un rapido giro di telefonate, saluti ed abbracci. Mi sono sentita dire di tutto. Che non ce l’ho fatta. Che era una pazzia. Che mi sarei pentita. Che non me ne fregava più un accidente di niente. Che mi sono lasciata abbattere. Che non ho né pelle né palle. E un sacco di altre superficiali idiozie più o meno lecite. Ero veramente convinta della mia decisione. Vado a vivere in Australia
, dicevo. Mi ci sono trasferita per poco. Sono successe cose, ho conosciuto gente. Persone. Sono tornata a casa. Casa. Cos’è casa? Sono tornata in Italia e niente è andato come previsto. Non volevo altri animali e ho adottato tre tartarughine, una coppia di criceti che si è presto tramutata in una quarantina di pelosissimi esemplari striati, un fidanzato e un cane.
Ripenso alla stanchezza. Alle notti in ospedale. Ai miei pazienti. All’amore che ho dato loro. A quello che loro hanno dato a me. A quello che mi convinco mi abbiano dato. Che non voglio dare per scontato, ma di cui ho bisogno.
Ho un dannato bisogno di sapere che io, per loro, qualcosa contavo. Che io, per loro, non sono stata soltanto una comparsa in divisa bianca con bordi arancioni e cartellino sulla chiappa a mo’ di vacca da carne
Ripenso alla monotonia, alla quotidianità che non sopportavo più, alla frustrazione del non riuscire a superare un dannatissimo esame dal quale sembrava quasi dipendesse il mio futuro, alla mia voglia di vivere, di libertà, sopra ogni cosa. Di libertà. Ripenso a quella moneta, quella che ho lanciato per decidere, come se già, dentro di me, non avessi la risposta. Ripenso a quando ho detto: Mamma, ma se io davvero andassi in Australia?
. E a quando, tre mesi dopo, mi sono ritrovata su un autobus carico di rabbini (ok, a dir la verità era soltanto un ebreo, ma nella mia testa rimarrà sempre Il Rabbino), aborigeni più o meno sboccati e grondanti di alcool (ma anche di senso dell’ospitalità e di una certa galanteria) e altra gente viaggiante, su una strada di cui non conoscevo la fine, che tuttora non so dove portasse, circondata da cartelli di cui nemmeno riuscivo a pronunciare i nomi, con le vesciche sulle mani, la schiena a pezzi, l’odore di pioggia che si mescolava a quello di salviette intime-multiuso-gettabili nel wc, cibo di aereo, corridoi di aereo, sedili di aereo, nastri trasportatori e curiosità. Senso di abbandono, di accoglienza, di ritrovo. Di gratitudine. Di sottile ansia. Di istintiva fiducia.
Ripenso a me e alla mia versione infermieristica. Sì, lo ammetto, quella vita mi manca, qualche volta. Mi manca l’odore della divisa appena lavata. Mi manca lo sguardo dei pazienti. Mi mancano persino i campanelli di chiamata che suonano continuamente per i corridoi a qualsiasi ora del giorno o della notte per motivi più o meno gravi, da quello che si sta soffocando a quello a cui è caduto il telecomando per terra. Mi mancano le luci lampeggianti, i gesti di quella quotidianità. Mi mancano quelle notti insonni. Mi manca cambiarmi nello spogliatoio. Le rampe di scale. La pelle d’oca verso mattina. Mi manca il senso di vuoto alle ginocchia. Mi mancano i piedi doloranti dopo undici ore di zoccoli blu. Mi manca il mio senso di smarrimento davanti a certe disumanità. Come quella volta in cui una collega disse, a proposito di un paziente appena ricoverato: “Ha due figli. Nell’incidente stradale ha perso la moglie. Oltre che la mano”. “E cosa c’entra la moglie?”, rispose brusca un’altra. O come quando assistetti a un aborto e durante l’operazione le infermiere si misero a parlare dei propri figli. Ecco. Mi manca il mio non saper cosa dire di fronte a quelle situazioni. Mi manca il rumore dei ferri chirurgici. Mi mancano i sorrisi dei bambini.
Mi manca pressoché tutto, di quel mondo. Perché sì, quello è un mondo a parte. Mi mancano le lacrime che mi costringevo a inghiottire quando ero io a sapere la diagnosi prima del paziente interessato. Ripeto, il mondo sanitario non è soltanto questo. Non è soltanto dolore, tutt’altro. Ed è questo, quello di cui sento la mancanza. La componente del bene. L’essenza che spinge un essere umano a prendersi cura di un altro essere umano. Nonostante tutto. Mi manca sentirmi chiedere: Ma perché hai scelto questa professione?
. E non saper cosa rispondere. Voglio dire, perché è la cosa giusta da fare, no? Mi mancano i miei blocchi da disegno schizzati di antibiotico. La mia camicia, schizzata di antibiotico. No, non è vomito, questo, è antibiotico, davvero.
Non ho mai pensato che sarebbe stato facile. Ma la verità è che ci si abitua a tutto. Dicono che per fare il medico o l’infermiere ci voglia una sorta di vocazione. Forse è vero, sotto certi punti di vista, ma più che vocazione la definirei devozione alla vita. Ci vuole stomaco, su questo non c’è dubbio. Ci vuole sangue freddo. Ci vogliono lucidità nei momenti di emergenza ed empatia in ogni altro momento. Ma la verità è che ci si abitua a tutto. Ci si abitua alla vista del sangue. Ci si abitua al rumore delle seghe che amputano arti. Si impara a non svenire. A non cascare a terra lunghi distesi come sogliole. Ci si abitua al dolore. Si impara a dire si è fatto tutto il possibile
. Ci si abitua a lasciare andare. A salutare cortesemente i pazienti che, finalmente, vengono dimessi. Senza piangere. Senza frignare. Senza dir loro mi dispiace che tu te ne vada
. Perché è chiaro che è una buona cosa, il fatto che siano guariti. Ci si abitua al rumore delle martellate al naso. Ai pannoloni da cambiare. Ci si abitua ai turni di notte. Ai farmaci da sciogliere che, puntualmente, non ne vogliono sapere di sciogliersi, quando si è di fretta. Ci si abitua alle flebo da sostituire. Alle domande dei parenti. Si impara ad effettuare un cateterismo venoso senza dissanguare nessuno e senza ritrovarsi schizzati di sangue (altrui) dalla testa ai piedi in stile cascate del Niagara. Ci si abitua a entrare in contatto con altri corpi.
Sapete, essere infermieri è qualcosa di intimo. Più intimo del sesso
La linea tra l’entrare in contatto e la violazione è sottile. Ci si abitua all’odore del sangue. A quello dell’urina e di qualsiasi altra cosa. Ci si abitua a lavare i denti a un altro essere umano e volendo, anche a farlo con un sorriso. Ci si abitua a usare il defibrillatore. A fare un massaggio cardiaco. A sentire la consistenza delle costole e della sofferenza. A toccare pezzi di intestino, a guardarci dentro, a sciacquarli sotto al rubinetto. Ci si abitua a veder compilare cartelle cliniche, lettere di dimissione, prescrizioni di esami. Si imparano i trucchi del mestiere. Si impara ad amare. A fare diagnosi. A lasciar andare. Si impara a fare una trasfusione adeguatamente senza fare boiate come appoggiare la sacca di sangue sopra al termosifone per scaldarla un po’. Perché c’è chi lo ha fatto, sì, e la sacca si è sciolta. Tutto il resto ve lo risparmio. Ci si abitua a un sacco di cose. Volenti o non.
Ma certe volte, al di là di qualsiasi immaginazione, il corpo si ribella. Si stanca di quella routine. Inizia a porsi nuove domande. Non sopporta più il dolore. Non accetta la fine della vita. Trema soltanto all’idea di quella parola. Non riesce a pronunciarla. Non l’accetta più. M. O. R. T. E. Ma il concetto è che ci si può abituare a tutto, sotto certi aspetti. Si può essere infermieri “bravi o non bravi”, “umani o non umani”, “belli o brutti”. Ma credetemi, per tenere in mano un setto nasale piuttosto che un testicolo reciso, non ci vuole nessuna cavolo di vocazione, ok? Ci vogliono stomaco, lucidità, autocontrollo e mano ferma. E possibilmente anche un bel paio di guanti. La verità è che ho lasciato per lo stesso motivo per il quale avevo scelto questo percorso. Un micidiale meraviglioso senso di attaccamento alla vita.
Se adesso, dopo anni di "Qualsiasialtracosa&TuttoIlResto", mi troverò nuovamente in un corridoio d'ospedale a canticchiare con un mazzo di cateteri in mano, piuttosto che a memorizzare poesie in sala operatoria, sarà - in una forma o nell'altra - solo e soltanto per lo stesso motivo.
Olimpia, studentessa



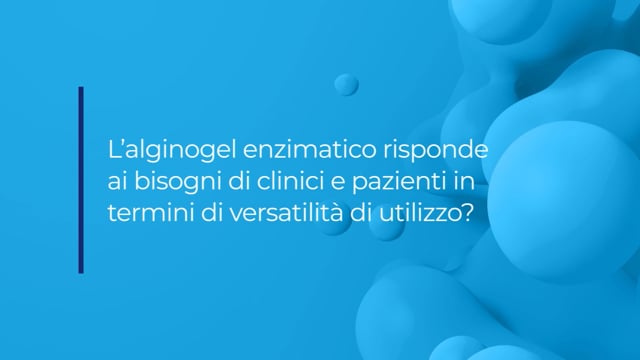







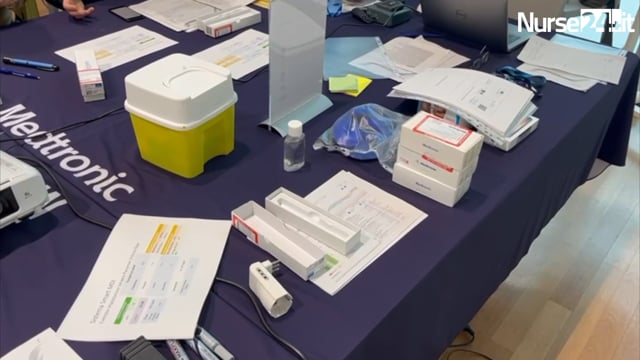






Commento (0)
Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?