È difficile parlare di fine vita, sia per il paziente che per il professionista sanitario. Ognuno vi si approccia con prospettive diverse. Si tratta di un momento intimo e delicato con significato particolare, legato alla propria storia personale, che dipende dal vissuto e dalla personalità, dai valori e dalla cultura di appartenenza, nonché dai modi di pensare alla vita e alla morte.
Quando gli infermieri si sentono impotenti di fronte a sofferenza e morte

Dalla revisione di numerosi articoli emerge che gli infermieri dichiarano di sentirsi impotenti di fronte alla sofferenza e alla morte.
Per essere accompagnatori di un'altra persona che è prossima al suo fine vita l'infermiere deve interrogarsi sulla questione, chiedersi cosa significhi per lui il morire e pensare a come si vuole vivere il proprio ultimo periodo della vita. Anche solo parlarne crea inconsapevolmente un disagio che si cerca di allontanare con vari meccanismi di difesa
.
Così Mariangela Mettifogo, infermiera psicologa e psicoterapeuta nella sua relazione sulle competenze infermieristiche durante il fine vita, di cui si è discusso all’evento ECM organizzato da Opi Vicenza il 15 dicembre scorso.
Come sanitari viviamo una dissonanza nel dualismo di cui siamo fatti. Abbiamo infatti un io-persona che si integra con un io-professionista: siamo individui con le nostre caratteristiche peculiari e con un mandato – che ci siamo dati e che la società ci ha assegnato – di affrontare ogni giorno la malattia e la sofferenza delle altre persone per cercare di farle guarire e di posticipare il più possibile il loro fine vita
, spiega Mettifogo.
Siamo persone costrette a guardare abitualmente in faccia la morte: il nostro vissuto personale ci porterebbe naturalmente ad allontanare da noi il pensiero della morte ma come professionisti certamente non possiamo rimandare l'incontro con essa, occupandoci di sofferenza e malattia. A contatto con la morte ci rendiamo conto della nostra fragilità e vulnerabilità, nonché dei nostri limiti sia come sopravvivenza in quanto persona sia come possibilità di cura in quanto professionisti della salute. Ci imbattiamo nella nostra limitatezza anche nei confronti di una fatica fisica e di un distress lavorativo che consuma le nostre risorse e fa scontrare le nostre potenzialità con le aspettative degli altri verso la nostra figura
.
Racconta che assistere alla morte dei pazienti, in maniera improvvisa ed imprevista oppure come accompagnamento, è una esperienza comune a tutti gli infermieri, a seconda degli anni di servizio e del contesto di lavoro, che può essere vissuta in modo traumatico – quando ci coglie impreparati e di sorpresa, magari all'inizio della professione – oppure in modo faticoso perché ci ha mosso delle emozioni forti.
Restano esperienze che ci portiamo dentro. Anche senza averne consapevolezza, tendiamo a dimenticarle. La mente le accantona nel preconscio e nell'inconscio per proteggersi da eventi forti. Restano così nascoste ma riescono ad influenzare il nostro modo di approcciarsi alla persona che è in fine vita.
Dalla revisione di numerosi articoli emerge che gli infermieri dichiarano di sentirsi impotenti di fronte alla sofferenza e alla morte, di non riuscire ad essere di aiuto e di non saper trovare parole di speranza e di conforto.
La speranza è intesa come un sentimento di fiduciosa aspettativa nella realizzazione presente o futura di quanto si desidera. Si fa fatica a dare speranza quando c'è già una diagnosi di malattia incurabile e una prospettiva di fine vita proprio perché abbiamo associato e identificato la speranza solo con la possibilità di cura
, continua Mettifogo.
Siamo pertanto portati a non vedere speranza laddove non c'è più possibilità di guarigione. Ci troviamo così disarmati, in disagio e in difficoltà ad avvicinarci alla persona che soffre e che sta morendo
. Molti studi hanno evidenziato invece che la speranza esiste anche nelle cure palliative, dove diventa preziosa risorsa che può migliorare la qualità di vita del paziente.
La speranza, infatti, viene trasmessa non soltanto con le parole, che fatichiamo a trovare, ma anche con il linguaggio non verbale (gesti, comportamenti, espressioni, vicinanza fisica). La speranza viene intesa dai pazienti piuttosto come un'emozione generata dal conforto e dalla pace del presente, secondo alcuni studi che hanno raccolto le definizioni più significative.
Speranza non è quindi soltanto idea di sopravvivenza e guarigione. Essa viene frammentata, non nel senso che si rompe e cade a pezzi, ma viene diluita e ridistribuita su obiettivi più fattibili, concreti, prossimi
.
Gli studi evidenziano che i professionisti, di fronte al fine vita, esprimono vissuti che generano impotenza, tristezza, senso di colpa. Si sentono svuotati. Stare accanto al dolore della persona sofferente e con una malattia incurabile e in prossimità del fine vita muove sensazioni spiacevoli che si cerca di compensare con il desiderio di alleviare la solitudine del paziente, dandogli sostegno e comfort.
Certamente viene anche naturale sottrarsi da tali vissuti emozionali ed esperienziali, attivando meccanismi di difesa, nel tentativo di proteggersi da eventi che sembrano destabilizzare. Ma riuscire ad entrare nelle relazioni, nonostante sia difficile, è curativo non solo per il paziente ma anche per il professionista.
Aiutare il malato ad orientarsi nelle scelte difficili legate al fine vita, dal percorso più adeguato sino alla pianificazione condivisa delle cure, significa anche sostenerlo in tali scelte anche quando le rifiuta ed accettare quando decide qualcosa che non è conforme ai nostri valori e al nostro sapere clinico. Proviamo disagio ed entriamo in crisi perché si manifesta una dissonanza tra quello che sentiamo e crediamo e quello che dobbiamo fare. Vi è poi il moral distress, lo stress morale che l'operatore sanitario vive nel momento in cui sa qual è il bene per la persona, anche eticamente, ma si trova di fronte a dei limiti - istituzionali, organizzativi e normativi - che gli impediscono di realizzare quanto è bene per il paziente. Ed il fatto di sapere di non poterlo aiutare sottopone allo stress lavoro correlato che può portare al burnout
.
Attivare difese per proteggersi dalle situazioni difficili non fa bene alla relazione d'aiuto con il paziente. I meccanismi di difesa sono necessari laddove è necessario tutelarsi, qualora non si abbiano in certi momenti risorse adeguate per affrontarle, ma occorre prenderne consapevolezza affinché non diventino resistenze e modalità di comportamento abituale.
Per porci in ascolto autentico verso il paziente, che vive un momento esistenziale di fragilità e vulnerabilità date dalla malattia, occorre riconoscere innanzitutto il proprio disagio ed indentificare le nostre aree di debolezza e difficoltà a sostenere la relazione.
Dobbiamo comprendere che abbiamo di fronte una persona che può provare sentimenti contrastanti, talvolta inconciliabili passando dalla rabbia alla profonda tristezza. Ci si deve chiedere se riesce ad esprimere le emozioni e quanto esse condizionino le sue scelte, se vuole parlare del proprio fine vita o se preferisce piuttosto concentrarsi sul suo presente, aggrappandosi all'idea della sopravvivenza e di avere ancora possibilità. Bisogna chiedergli cosa sa e cosa vuole sapere ricordando che ogni malato ha il suo modo di affrontare la malattia, una prognosi infausta e la possibilità di morire, a seconda della propria storia personale e delle sue risorse
.
È il paziente che è ansioso, che ha paura di morire e che è arrabbiato
, ci si dice per nascondersi, ma in realtà l'ansia, la paura e la rabbia sono le nostre. La psicoterapeuta ritiene che questo meccanismo diventi pericoloso quando si proietta sull'altro le proprie idee per soddisfare un proprio bisogno a tal punto che ci si convince che sia l'altro a volerlo.
Tali sistemi di difesa non devono tuttavia essere un modo abituale di interagire e di relazionarsi. Se persistono la difesa diventa resistenza che fa male alla relazione perché non si riesce più a rispondere ai bisogni reali del paziente e fa male al sanitario che non avrà più conferme di essere un professionista valido e capace.
La possibilità di un fine vita pone la persona a vivere uno stato di sofferenza, un dolore che viene definito totale, non solo fisico, perché coinvolge anche la dimensione psicosociale, la cui risposta non puo essere soltanto farmacologica. Riconoscendo che ogni persona reagisce e vive la malattia in maniera diversa, ci si deve predisporre all'incontro relazionale con il malato in maniera né da esserne travolti né da travolgere l'altro. Si deve sapere che se ci si espone, senza essere preparati e con adeguato sostegno, a situazioni potenzialmente destabilizzanti si corre il rischio a lungo termine di consumare le proprie risorse
.
Si rende pertanto necessario, suggerisce la psicologa, ricercare aiuto nella condivisione con i colleghi o altro tipo di sostegno se il vissuto personale diventa problematico. Non travolgere l'altro significa rispettarlo in tutte le sue fasi anche quando ha bisogno di prendere tempo per mobilitare le risorse di cui ha bisogno per affrontare la sua malattia.
Occorre dare significato al nostro agire anche nel fine vita. Se capita qualche volta, è normale fuggire dalle relazioni perché sono difficili, chiedono impegno, fanno paura e mobilitano emozioni troppo forti verso le quali non ci si sente pronti ma, in quanto professionisti, si devono trovare ad un certo punto le risorse per affrontare situazioni di disagio, per non perdere motivazione e professionalità.
Sottolineando che occorre prendere consapevolezza della non semplicità degli atti comunicativi (Rogers), Mettifogo spiega che la comunicazione nel fine vita deve essere direzionale associata all'osservazione dell'altro, nonché particolarmente attenta a scegliere parole adeguate alla comprensione del paziente.
Che siano misurate sulla sua volontà di sapere, ponderate sulla base del suo stato emotivo per non travolgerlo, riformulate sulle sue parole, tradotte in un linguaggio semplice. Le parole poi devono essere dotate di tempo ossia disponibili a ripetersi. Devono essere caratterizzate da sensibilità e comprensione, mai giudicanti e senza pregiudizio
.
E devono essere coerenti con i gesti della comunicazione non verbale, associate a comportamenti che favoriscano la comprensione e l'instaurarsi di una relazione di fiducia. È dimostrato infatti che i pazienti cercano conforto e rassicurazione dai medici interpretando le loro espressioni facciali e il linguaggio del corpo utilizzando questi segnali non verbali per determinare la presenza di empatia.



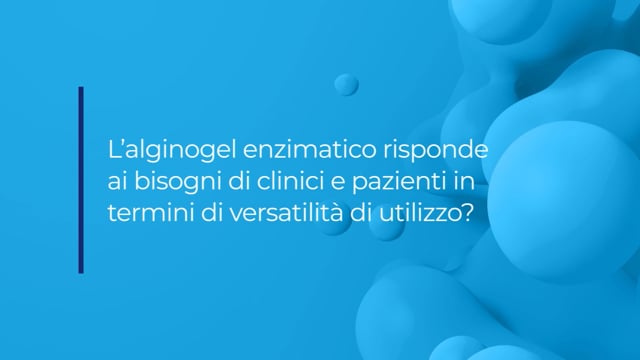







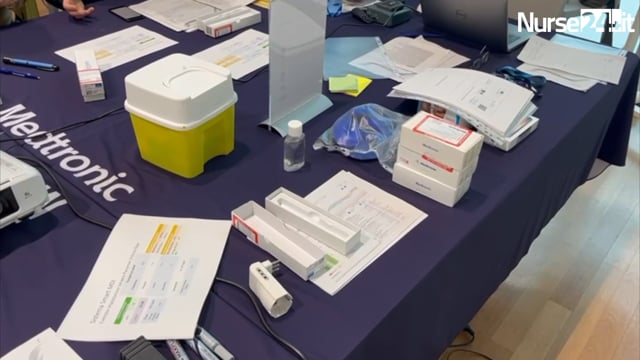






Commento (0)
Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?