Faccio decisamente un lavoro del cavolo. Intendiamoci, il mio lavoro mi piace, me lo sono scelto: chi ha la fortuna di poterlo fare? È che il mio lavoro mi ha tolto e dato nella stessa misura. In certe occasioni, rimani lì, spiazzata, senza sapere come agire, come sistemarlo nella tua vita senza intaccarla. Questo concetto dovrebbe trovare la sua espressione nel termine empatia: mettersi nei panni di qualcuno è uscirne quando il momento lo richiede. Dicono sia molto professionale. Ma io mi chiedo, come fai ad entrare nei panni di qualcuno e uscirne quando ti pare?
Cure palliative, dove ho ritrovato parti di me che sentivo così lontane

Il mio pensiero torna a loro due, stanza quindici
Se io decido di entrare nei panni di qualcuno non è che mi ci fermo cinque minuti poi dico: Scusa tanto, ora è il momento di andare. Torno fra un'ora per farti un clistere, mi infilo nei tuoi panni e così empatizzo con te!
Come si fa, dico io? Io non me lo sono mai fatta fare un clistere, agli altri ne ho fatti tanti e tutto sommato li faccio anche bene, esito quasi sempre positivo, ma in realtà non comprendo cosa si provi, quanta umiliazione si viva.
Poi ammettendo che entrare nei panni di qualcuno sia così semplice, com'è possibile vedere i suoi patimenti tanto da viverli e poi togliersene come se niente fosse?
Far finta che sei stata oltretutto professionale e visto che sei stata così brava, riuscire a passare a qualcun altro senza pensarci più. Tornare a casa e fingere che quello che hai vissuto per sette ore, sia frutto di un brutto scherzo della mente: a te non può succedere, ai tuoi cari nemmeno.
Ricacci tutto nel tuo ego di brava professionista, sei stata empatica, ora torna nei tuoi panni di giovane donna indipendente che non ha bisogno di troppe cose per essere felice. I tuoi tre gatti, Zeus, Fulmine e Saetta ti corrono incontro appena sentono girare le chiavi nella serratura: hanno fame, non mangiano da stamattina quando sei uscita per andare al lavoro. Apri la scatoletta di umido salmone-trota: il profumo è sfizioso anche per gli umani e ti ricordi di non aver nemmeno pranzato.
Il tuo pensiero torna a loro due, stanza quindici: deliziosa, c’è tutto. Letto articolato, televisore, terrazzo, bagno e un vano in cui è stata ricavata una cucinetta con frigorifero e piano cottura. Nella stanza c’è anche una poltrona che diventa letto, per il familiare che desidera fermarsi per la notte.

Con il tempo hai imparato ad apprezzare quell’accostamento di colori che tanto ti schifava prima: rosa salmone e verde. Ogni volta che entravi nelle stanze, i primi mesi, trovavi veramente bizzarro chi avesse progettato quel posto. Il reparto era nuovissimo ed eri fra le infermiere che ne avevano inaugurato l’apertura.
Non ci volevo venire a lavorare in questo posto... Tu salvi vite
, ti ripetevi come un mantra per scacciare quella proposta che ti avevano fatto: cure palliative, hospice, dove la gente va a morire.
Erano richieste competenze relazionali: per questo non capivo perché me lo proposero (poi in seguito compresi che pensarono a me perché ero vicino a casa. Il posto era dislocato dall’ospedale principale di circa 20 chilometri e questo poteva essere un limite per altri infermieri: insomma pensavano di farmi un favore, vicino a casa, a due passi da casa).
Dissi di no, opposi resistenza, ma alla fine mi convinsero almeno a provare. Prima di questo avevo intrapreso altri ambiti lavorativi e la dote relazionale che maggiormente mi veniva riconosciuta, era quella di mettere sicurezza anche alle altre figure professionali.
Ho lavorato in reparti molto tecnici e percepivo che un operatore lavora al meglio se messo in condizioni di tranquillità. Anche nelle emergenze, se mi veniva richiesta una prestazione da un medico o da un collega, io la ripetevo con calma e chiarezza ad alta voce, in modo di essere sicura di ciò che mi era stato chiesto e l’altro operatore certo di ciò che aveva detto.
A volte capitava che alcuni, durante le emergenze, si facessero prendere dal panico urlando, o forse era solo un modo per scaricare l’adrenalina, ma l’unico effetto che ottenevano era quello di agitare tutti gli altri e il paziente stesso, rischiando di creare il panico e generare quindi l’errore.
Io agivo sempre nel medesimo modo, con uno schema mentale prefissato: l’esterno non esisteva, solo l’équipe e il paziente, che però in quel momento era poco più che “qualcosa su cui armeggiare”.
Nell’emergenza, se il paziente è incosciente è una benedizione e quando no lo è si cerca di far di tutto per sedarlo: in quei momenti l’unica cosa importante è che il suo cuore, i suoi polmoni e tutti gli organi tornino a funzionare con regolarità. Non importa chi è, quanti anni ha, se ama sua moglie, cosa sta provando, quello che importa è ristabilire un ordine nel suo organismo.
Giusto, nobile. Salvare vite è uno degli scopi più sacro al mondo: l’emergenza mi mandava in circolo un’adrenalina tale che mi faceva sentire più forte. Il riscontro coi pazienti e i famigliari era però devastante.
Avevo fatto diversi corsi sull’empatia e sull’ascolto, ma in realtà quello che mi veniva chiesto era di dare informazioni chiare e se potevo con un po’ di educazione, il resto era teorico, quello che davo in più a livello comunicativo era frutto del mio carattere e non di una serie di competenze acquisite.
A volte succedeva che se mi avvicinavo di più ad un paziente ero più portata all’errore, perdendo di vista le procedure da applicare. Quindi tornai sui miei passi, niente più empatia o ascolto: se volevo essere un operatore capace, dovevo delineare un confine fra me e loro.
Andavo avanti così, un’infermiera molto capace, ma molto rigida: non potevo permettermi di perdere lucidità, non potevo avvicinarmi ai pazienti, dovevo mantenere le distanze e forse avrei continuato a pensarla così se non mi fosse capitata la proposta delle cure palliative.
L’emergenza non è più l’arresto respiratorio, un infarto, un trauma. L’emergenza diventa il dolore nella sua totalità, si cerca di arginare la sofferenza, l’agitazione fisica e tutti quei sintomi che compaiono nella malattia oncologica e non, in fase avanzata.
Non si cerca di far funzionare un organo, si prova a rendere un percorso di malattia meno impervio. Non dovevo più salvare, dovevo lenire e questo era davvero uno sconvolgimento mentale nei miei parametri professionali.
All’inizio mi sentivo non all’altezza in quanto si trattava non solo di trattare sintomi, ma anche rassicurare, toccare, lenire… doti non comprese nel mio bagaglio lavorativo fino ad allora.
Il mio inizio in cure palliative sembrava piuttosto in salita: il contatto fisico con gli estranei mi impauriva, le competenze relazionali mi parevano un trattato aramaico, ma c’era qualcosa che mi incuriosiva: dovevo capire se ero in grado di apprendere qualcosa di totalmente nuovo nel mio modo di lavorare
In quei momenti ero scettica, ma ero anche assetata di sperimentare. Del primo periodo in cui iniziai a lavorare, ricordo i tempi prolungati: improvvisamente avevo tempo per fare le cose con calma, ascoltando i pazienti, potevo capire i loro sintomi.
A volte dicevano che avevano smania, ma se stavi un po’ ad ascoltare come descrivevano il loro malessere, capivi che avevano dolore e potevi intervenire per aiutarli.
Poi la testa torna a stamattina. A loro due, quelli della stanza quindici, moglie con cancro al seno metastatizzato, in fase avanzatissima ed un marito spaventato di perderla, un uomo innamorato che però non ha più tempo di praticarlo quell’amore.
Lo vorrei io uno che mi guarda così: Che dici, stupida? Sta crepando...
Però penso che a me un uomo con quegli occhi lì non mi ha mai guardato: non è pietà, è terrore di perderla. Li ho sorpresi. Erano in silenzio, mentre lui cercava di sollevarla dal letto e lei si aggrappava al suo collo incrociando le dita contro la sua nuca, ma non riuscendo a farsi forza, si slacciavano facendo ricadere le braccia sul letto. Quando mi hanno visto, non hanno fiatato, mi hanno solo guardato sorpresi, come se li avessi scoperti in una strana intimità.
Sorrido accennando un “Torno più tardi” e lei con un filo di voce mi risponde: Ci hai beccati ormai! Fai quello che devi fare. Tanto per quello che facevamo noi, ormai ci vogliono ore, tu farai sicuramente prima! Non pensavo ci volesse così tanto per muovere quattro ossa!
.
Le rispondo che è tutta questione di tecnica, che scommetto che uno scricciolo come me, l'avrà vinta su quell’energumeno di suo marito. Continuo a scherzare, insegnandole i movimenti che le permettono di risparmiare più ossigeno e bruciare meno calorie.
Lei mi guarda stupita, mentre la sollevo dalla posizione seduta a quella eretta, senza farle usare neppure la fibra di un muscolo. Continuo a sostenerla, ma comincia a mantenersi stabile. La accompagno nelle mani del marito, insegnandogli come sostenerla senza farle male. Lascio le dieci compresse delle otto ed esco dalla stanza.
Chiudo la porta per far loro capire che sono liberi di non parlarmi se vogliono rimanere nella loro intimità, ma so già che dopo dieci passi, sentirò aprire quella porta alle mie spalle. Mi giro, fingendo una sorpresa comprensione. Lui mi cerca con gli occhi spauriti, braccato. Mi si avvicina, so che è importante che sia lui a venirmi incontro, non devo forzare nulla, deve essere lui a scegliermi, se vuole, può non aprirsi e non chiedermi aiuti, devo lasciarlo libero di poter scegliere.
Si asciuga alcune lacrime col dorso della mano, più come gesto istintivo che per non farsi vedere da me. Mi scruta per cercare una risposta nei miei occhi che gli appaiono più capaci. Lo accolgo con un sorriso che credevo privo di empatia, solo ricco di rispetto; in realtà capisco che è uscito spontaneamente, verso un uomo in difficoltà.
Penso già che non ne uscirò da questa storia, ma il fatto che non abbia voluto entrarci a tutti i costi, ma sia stata scelta, mi rassicura sul fatto di non essermela cercata e decido consapevolmente di dare un po’ di me a questo uomo: un po’ del mio saper fare, un po’ della mia conoscenza e un po’ della mia compassione, ma anche un po’ della mia grinta e, perché no, anche della mia dolcezza che mi sembrava così lontana, così nascosta.
Samanta Fabbri, Infermiera



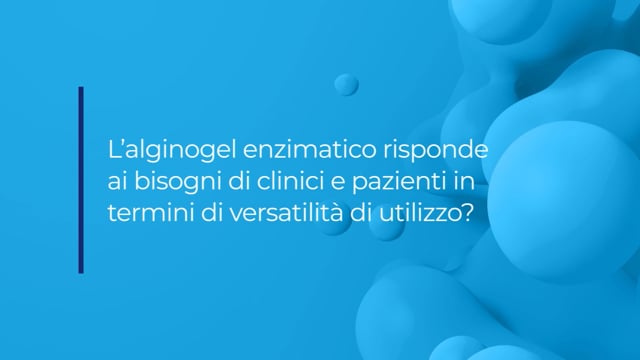














Commento (0)
Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?