Molto da dire, ed ancor più molto da fare, per questo 1° maggio 2022. Per chi vuole capire il perché di questa festa è sufficiente che ripensi a precisi particolari del passato, al quadro sociale del presente e alle tragedie che ogni giorno si consumano sul posto di lavoro rubando il futuro a troppe famiglie. In tutto ciò la storia e l’attualità sottolineano la forza dei lavoratori quando sono risoluti e uniti nel rivendicare diritti e giustizia sociali, per chi lavora e per tutta la società, liberi da qualsiasi propaganda tossica o strumentale.
Quando (e quanto) sul lavoro si muore

1 maggio 2022, la festa dei lavoratori
Perché esiste la festa del primo maggio lo si è scritto un paio di anni fa, in pieno confinamento da Covid-19. La forza rivendicativa di quella che è una festa è stata poi ribadita lo scorso anno. Oggi verrebbe voglia di dire molto di più, a fronte di un bollettino di guerra dei morti sul lavoro che viene aggiornato drammaticamente.
Parlare poi di guerra di questi tempi sembra facile retorica, eppure altro termine non può essere usato, riguardo la presenza inaccettabile di un alto numero di infortuni e decessi nei luoghi di lavoro connotati sempre da precariato, insicurezza, basse remunerazioni salariali. A tale proposito qualche cifra può essere fornita.
Nel 2019, prima della pandemia, in Italia le denunce di infortunio sul lavoro sono state 642 mila. I dati dei primi due mesi del 2022 mostrano un aumento della mortalità del 25% (pari a 3,7 morti al giorno) in alcune regioni italiane: Toscana, Sicilia, Molise e Marche, e le denunce presentate all’INAIL già arrivano alla cifra di 121.994, per un aumento del 47,6% rispetto alle 82.643 dello scorso anno, e del 26,4% relative alle 96.549 del 2020.
In una prospettiva di più ampio respiro, il quadro di questi ultimi dieci anni evidenzia una media annuale di mezzo milione di denunce per infortunio e una totalità di circa 13.000 morti sul lavoro. I numeri sono impietosi ma se, nonostante tutto, non bastassero, allora si può partire più prosaicamente, e banalmente, da una cena fra infermieri anziani.
Un collega, qualche giorno fa, mi ha raccontato di essere stato contattato da un vecchio compagno di scuola – del diploma regionale di infermieri professionali – per una rimpatriata a 40 anni dal diploma. Bella cosa ritrovarsi dopo tanto tempo, meno però quella di rilevare il fatto che, come ha sottolineato il collega, fra i tanti suoi ex-compagni di scuola, ancora nessuno è andato in pensione.
Beh! Sarebbe ora, dato che l’assistenza infermieristica assicurata da un sessantenne in corsia o in ambulatorio o in altro servizio, rischia di essere fortemente condizionata da un numero maggiore di fattori negativi, rispetto a quelli postivi, di cui, parimenti, un giovane può essere portatore. La predominanza in Italia della baby boom generation fra gli infermieri, e fra i molti lavoratori in servizio, è un dato di fatto. Fra i sanitari rappresenta circa la metà dei lavoratori. Un invecchiamento che pesa su chi assiste e su chi viene assistito.
Va da sé che il pensiero corre al diritto di vedere riconosciuta la professione infermieristica come usurante e degna di poter aver garantita un’uscita dal lavoro ben prima di quaranta anni e più di carriera. Un fatto che dovrebbe valere per tutti, invertendo la tendenza del prolungamento della permanenza al lavoro fino a 67 o a 70 anni.
Qualcuno dirà che i giovani entrano nel mercato del lavoro oggi, fra precariato cronico e privatizzazione della previdenza, avranno bisogno di almeno mezzo secolo di contributi per poter avere una vecchiaia serena degna di questo nome. Il rischio è che non basterà lavorare neanche fino ad ottanta. In questa prospettiva i neoassunti cercheranno di arrivare a sviluppare carriere che garantiscano nel tempo lavori meglio retribuiti e meno faticosi, mettendo in atto i classici meccanismi di sempre: nepotismo, clientelismo, fidelizzazione e una perenne e distruttiva guerra fra poveri.
Una corsa disarticolata, in quanto fuori da qualsiasi progetto di vita e di contesto molto spesso, ad accaparrarsi il titolo di studio che in primo luogo fa punteggio e poi permette di salire la scala sociale in una società, quella italiana in particolare, in cui l’ascensore sociale è fermo però al piano. Da anni. Anzi, sempre più spesso i figli trovano lavori peggiori dei padri.
Necessario dunque far sentire la propria voce e ricordarlo in un giorno – il primo maggio – che da sempre rappresenta la Pasqua di riscatto dei lavoratori? Certo. Lunedì scorso migliaia di infermieri hanno scioperato presso lo Stanford and Packard Children’s Hospital di Palo Alto in California per vedere aumentato il salario e migliorate le condizioni di lavoro in termini di carichi di lavoro e stress psicologico.
Le scorse settimane i medici e gli infermieri dell’ospedale pediatrico di Colombo, capitale dello Sri Lanka, hanno scioperato contro l’aumento del costo della vita, l’impennata dei prezzi dei carburanti e dei beni di prima necessità e la grave carenza di farmaci. In Italia, quasi negli stessi giorni, sono scesi in piazza molti lavoratori in sciopero contro la guerra in Ucraina chiedendo più risorse per la salute che per le armi. Qualcuno ha detto che quello era uno sciopero politico e non aveva ragione d’essere. In realtà è una sciocchezza retorica utile solo a delegittimare lo sciopero, dato che esso è uno strumento di rivendicazione sindacale dei diritti dei lavoratori proprio contro scelte politiche ben precise: profitto, guerra, disuguaglianze, etc.
Già, le disuguaglianze
In merito è necessario sottolineare come queste, secondo un recente rapporto dell’OMS, non solo siano aumentate, ma abbiano avuto un importante ruolo nella diffusione del contagio da Covid-19. Al di là delle baggianate diffuse dalle diatribe fra pro-vax e no-vax, i dati rilevano come le persone maggiormente colpite sono quelle caratterizzate da svantaggio socio-economico: detenuti, immigrati, poveri, anziani in strutture residenziali, senza tetto, uniti ai lavoratori dei settori alimentari, sanitari e di altri servizi essenziali, molto spesso stressati e costretti a lavorare in condizioni di insicurezza, legate in particolare a maggiori tempi di esposizione al virus e/o all’essere portatori di malattie croniche o all’impossibilità/incapacità di aderire alle prescrizioni e misure sociali adottate contro il contagio (confinamento domestico, uso dei DPI, abitudine al lavaggio delle mani, etc.).
A tutto ciò l’OMS aggiunge l’attenzione sulla presenza o meno della copertura sanitaria offerta dai servizi e dei problemi (limitazioni) di accessibilità agli stessi. Un quadro reso ancora più grave nei casi in cui la ridefinizione dell’offerta sanitaria abbia provocato minor copertura in particolari situazioni di malattia, come nel caso della salute mentale, delle patologie oncologiche o in quelle rare, che poi… tanto rare non sono visto che nella complessità e totalità, sommandole fra loro, interessano sempre più larghi strati della società. Da ultimo, ma non meno importante, la pandemia ha aggravato molti fattori legati ai determinati della salute e della malattia, dal lavoro all’istruzione, dall’abitazione ai redditi, dall’offerta dei servizi fino alla tenuta delle reti sociali.



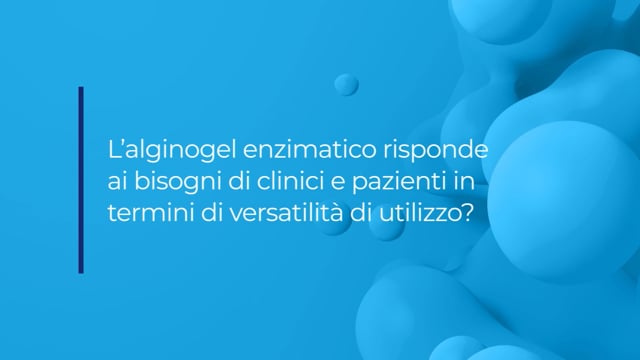














Commento (0)
Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?