La condizione clinica caratterizzata da un ristagno di linfa, espressione di un sistema linfatico compromesso, è definita linfedema. La linfa, che scorre lungo i vasi linfatici, viene veicolata nei linfonodi, specifici centri di filtraggio e depurazione. Si instaura un quadro di linfedema quando i vasi linfatici non sono in grado di drenare la linfa in maniera adeguata e si verifica un esagerato ed anomalo accumulo di fluido interstiziale nei tessuti che provoca ostruzione, tipicamente negli arti inferiori e superiori. La condizione è un'affezione cronica invalidante che si verifica quando nell'organismo il normale flusso della linfa – sostanza indispensabile per rimuovere sostanze tossiche e liquidi che filtrano dai capillari sanguigni - viene ostacolato compromettendo l'efficienza del circolo linfatico, fondamentale per la naturale difesa dell'organismo dalle infezioni.
Come si manifesta il linfedema

Manifestazione linfedema arto inferiore
Secondo i dati epidemiologici dell'Istituto Europeo Oncologico (IEO) in Italia circa 350 mila persone soffrono di linfedema e si registrano circa 40 mila nuovi casi ogni anno, soprattutto donne tra i 30 e i 40 anni. Nel mondo si segnalano 300 milioni di casi, 1 persona su 20 viene colpita da linfedema per varie cause. Si tratta quindi di una patologia molto diffusa, a carattere evolutivo, disabilitante ed ingravescente.
Il linfedema si manifesta in maniera evidente con un gonfiore cronico ad un arto, nell'80% dei casi inferiore, coinvolgendolo interamente oppure soltanto nella porzione prossimale o in quella distale. Può interessare anche gli arti superiori, il viso, i genitali e il tronco.
Generalmente il linfedema è asimmetrico, ossia unilaterale e in tale circostanza un arto appare visibilmente più edematoso del controlaterale. A seconda della gravità della condizione patologica correlata, tale gonfiore può essere più o meno importante: da lieve sino alla elefantiasi, ossia quando un arto diventa estremamente grande con una grave ipercheratosi e dall'aspetto di pelle di elefante.
Il sintomo principale di linfedema è il segno della fovea, duro non comprimibile, di consistenza fibrosa. La parte edematosa progressivamente si indurisce e si infiamma provocando dapprima fastidio, poi dolore ed infine deficit funzionale.
Tipologie di linfedema
Si distingue tra linfedema primario (ipoplasia linfatica) e linfedema secondario (ostruzione o distruzione dei vasi linfatici).
Diagnosi di linfedema
La diagnosi di linfedema è clinica e si base principalmente sull'esame obiettivo. Le indagini strumentali - risonanza magnetica, tomografia computerizzata, linfoscintigrafia ed ecocolordoppler - concludono l'accertamento, confermano la diagnosi, identificano le sedi dell'ostruzione linfatica e permettono una diagnosi differenziale escludendo insufficienza cardiaca congestizia, insufficienza renale ed insufficienza epatica, condizioni cliniche in cui tuttavia l'edema è bilaterale.
La linfoscintigrafia è una tecnica per immagini che fotografa il sistema linfatico. Il test si esegue mediante iniezione di sostanze radioattive, radiocolloidi, direttamente nella regione sottocutanea relativa al distretto linfatico da analizzare permettendo di evidenziare il tratto del circolo in cui la linfa ristagna identificando così un'ipoplasia linfatica o la presenza di un flusso rallentato.
Come si cura il linfedema
Non esiste una cura specifica, definitiva, completamente risolutiva. Il trattamento consiste nell'esercizio fisico, nella mobilizzazione attiva e passiva dell'edema tramite l'elastocompressione e i massaggi e talvolta nell'intervento chirurgico.
Poiché la chirurgia è riservata soltanto ai casi molto gravi che compromettono seriamente le condizioni cliniche e la qualità di vita, le terapie attualmente disponibili non consentono una guarigione completa ma possono ridurre o rallentare la progressione della condizione e prevenire le complicanze. Hanno l'obiettivo terapeutico di decongestionare l'arto coinvolto attraverso il linfodrenaggio manuale, il bendaggio, la pressoterapia e i tutori elastici.
Gli obiettivi terapeutici sono mirati a ripristinare la funzionalità del sistema linfatico, ridurre la sofferenza fisica e psicologica e prevenire la comparsa di infezioni. In caso di linfedema secondario, è fondamentale trattare adeguatamente la patologia che è la causa di linfedema. Il trattamento previsto permette di gestire il linfedema con un programma terapeutico costituito da tecniche ed esercizi mirati che hanno l'obiettivo di ridurre quanto possibile l'edema e controllare il dolore.
Quando si combinano più trattamenti il regime terapeutico è detto terapia complessa decongestiva (CPD), che è il trattamento di prima linea. È da sottolineare che tale terapia non può essere tuttavia attuata in pazienti con ipertensione, diabete, paralisi, insufficienza cardiaca, infezioni acute della pelle, cancro o trombosi.
La gestione del linfedema prevede anche delle misure conservative. È fondamentale mantenere una adeguata igiene e cura della pelle, instaurare un regime dietetico che permetta di perdere peso se in sovrappeso, evitare i traumi e gli indumenti costrittivi, elevare l'arto colpito. Le misure preventive indicano di evitare fonti di calore, sforzi fisici eccessivi, abbigliamenti stretti.
Sono da evitare vaccinazioni, flebotomie, la misurazione della pressione arteriosa con bracciale sfigmomanometro e cateterismi endovenosi a carico dell'arto colpito. A seconda delle condizioni cliniche correlate possono essere prescritti alcuni farmaci per la cura del linfedema:
- antibiotici (cefazolina, clindamicina,penicillina)
- prodotti topici per la pelle (lozione di lattato di ammonio, urea topica)
- antielmintici
- agenti retinoidi (acitretina, tazarotene topico)
- benzopironi (cumarina, flavonoidi)
Il trattamento chirurgico, riservato ai pazienti che non migliorano con le misure conservative, permette di risolvere il gonfiore in modo significativo ma non è curativo, soltanto palliativo. Si può intervenire chirurgicamente per rimuovere un tessuto in eccesso dell'arto colpito da linfedema con una procedura detta fisiologica (per migliorare il drenaggio linfatico) oppure con una procedura escissionale per ridurre il carico correlato al linfedema.
La riduzione chirurgica permette quindi di rimuovere il grasso sottocutaneo e il tessuto fibrotico e di ricostruire i tessuti molli quando la qualità di vita è significativamente ridotta. Se il linfedema deriva da un trattamento medico o chirurgico, la comparsa di disabilità e lo stress emotivo sono tali da richiedere un supporto psicologico.


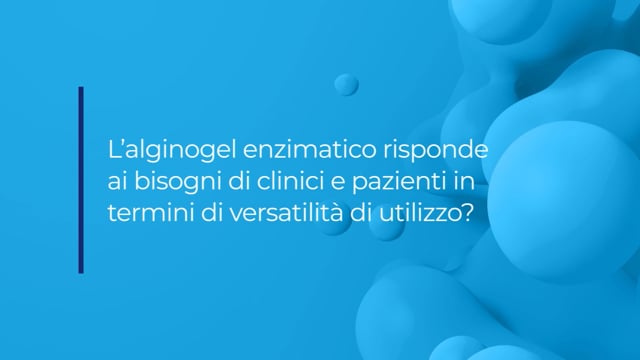






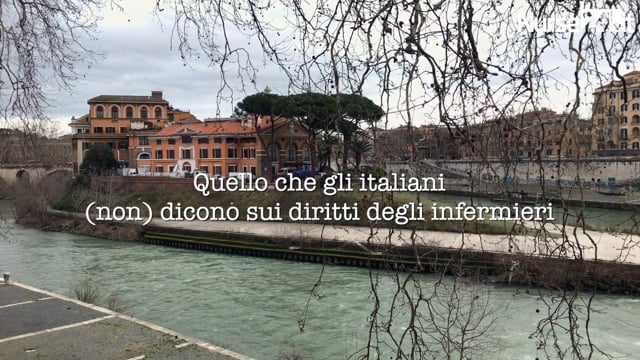
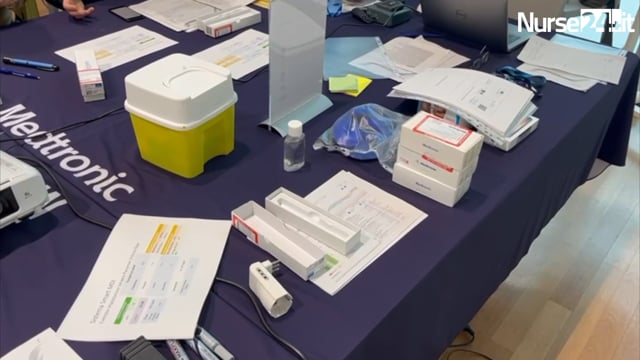






Commento (0)
Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?