Sala Operatoria
Esiste una significativa associazione tra i livelli di sicurezza psicologica e le percezioni sulla checklist di sicurezza chirurgica, la Surgical Safety checklist elaborata dall'Oms ed adottata in tutto il mondo mondo in sala operatoria dal personale sanitario, come pilastro fondamentale per garantire la sicurezza e l'accuratezza della comunicazione tra team. È il risultato di uno studio trasversale condotto da novembre 2022 a gennaio 2023 in Danimarca che ha coinvolto 125 operatori sanitari di cinque diversi gruppi professionali (anestesisti, ginecologi, infermieri anestesisti, infermieri di sala operatoria, specializzandi) nel reparto operatorio presso i Dipartimenti di Ginecologia ed Anestesiologia dell'ospedale Universitario di Copenhagen, una struttura che ha un elevato turnover di operatori sanitari e dove si svolgono 2500 interventi chirurgici ginecologici all'anno.
Indagine percezione dei sanitari su checklist di sicurezza chirurgica

La sala operatoria è un ambiente sanitario complesso ad alta pressione che richiede un'efficace collaborazione e comunicazione interprofessionale.
Dall'indagine emerge che gli operatori si sentono più sicuri psicologicamente quando hanno opinioni maggiormente positive sul ruolo della checklist nel migliorare il lavoro di squadra interdisciplinare, creando struttura ed attenzione tra i colleghi.
Quando invece vedono la checklist come uno strumento dispendioso in termini di tempo emerge che la loro valutazione di sicurezza psicologica è inferiore.
Considerando che al centro dell'implementazione di successo della checklist internazionale c'è il concetto di sicurezza psicologica e tenendo conto che un ambiente psicologicamente sicuro migliora l'apprendimento, le prestazioni e la segnalazione degli errori, l'indagine si è focalizzata per la prima volta non tanto sull'efficacia di questo strumento - di cui esistono numerose evidenze in letteratura - quanto piuttosto su come le percezioni dei professionisti sanitari a riguardo si intersechino con il loro senso di sicurezza.
I risultati suggeriscono che la sicurezza psicologica influenza il modo in cui gli individui vedono ed interagiscono con le misure di sicurezza del paziente, come la checklist. Evidenziano inoltre l'importanza e la necessità di promuovere un ambiente di supporto per ottimizzare la pratica di sicurezza, utilizzando in maniera coerente ed accurata questo valido strumento nei contesti clinici.
È infatti noto che, nonostante la sua dimmostrata efficacia, la Surgical Safety checklist non sempre viene utilizzata correttamente e conformemente alle disposizioni. I ricercatori sottolineano che la sala operatoria è un ambiente sanitario complesso ad alta pressione che richiede un'efficace collaborazione e comunicazione interprofessionale. I membri di un team devono quindi potersi sentire psicologicamente sicuri per lavorare bene.
Ciò significa sentirsi abbastanza sicuri da parlare delle loro osservazioni e preoccupazioni sulla sicurezza ed esprimere domande senza il timore di ripercussioni negative. Secondo gli autori, tale sicurezza nell'assistenza sanitaria è consentita da alcuni fattori organizzativi, di team e individuali.
La Surgical Safety checklist, il cui uso implica la conferma verbale che tutti gli elementi sono stati esaminati, guida costantemente e sistematicamente gli operatori sanitari attraverso una checklist completa in tre fasi con passaggi essenziali prima (accesso), durante (time out) e dopo l'intervento chirurgico (disconnessione).
La checklist garantisce che le informazioni critiche – l'identificazione del paziente, la verifica della procedura chirurgica e del sito, la presentazione del team, le complicazioni previste e la perdita di sangue stimata – siano comunicate in modo efficace tra tutti gli operatori sanitari presenti in sala operatoria, consentendo al team di essere preparato e gestire eventi previsti ed imprevisti.
Numerosi studi hanno dimostrato una netta diminuzione della morbilità e della mortalità dalla sua introduzione, tuttavia questi miglioramenti sono oggetto di discussione in quanto altri studi hanno riportato risultati divergenti, probabilmente per un uso scorretto o non conforme di tale strumento o per una attenzione limitata dalla cultura e dal contesto locale.
Secondo le linee guida dell'Oms gli ostacoli all'applicazione della Surgical Safety checklist includono le barriere individuali (resistenza, convinzioni, mancanza di leadership), ambientali (carico di lavoro, pressione del tempo, attività concorrenti) e culturali (specializzazione chirurgica, esercizio di spunta, indipendenza professionale).
Una delle pricipali scoperte di questo studio è stata che gli infermieri di sala operatoria hanno riferito di aver ricevuto una maggiore formazione sull'uso clinico della checklist chirurgica rispetto agli anestesisti, ai ginecologi e agli specializzandi. Inoltre hanno riportato, insieme agli infermieri anestesisti, un punteggio più alto per quanto riguarda la familiarità con tutti gli elementi del documento.
I ricercatori ritengono che ciò sia dovuto al fatto che gli infermieri specializzati seguono costantemente una formazione sistematica che li aiuta a mantenere le competenze, sebbene quelli di anestesia ruotino spesso in reparti diversi a differenza di quelli di sala la cui formazione dipende dal reparto locale a cui sono assegnati.
Medici e specialializzandi, che non ricevono invece alcuna formazione formale riguardo alla checklist, suggeriscono di avere a disposizione una checklist visibile in sala operatoria per facilitare una revisione più strutturata e coerente.
Molti studi hanno dimostrato infatti che ciò aiuterebbe a supportare tutto il team e non solo gli infermieri, che tendono a memorizzare meglio le informazioni contenute nella checklist in quanto devono spuntare tutti gli elementi nelle cartelle cliniche elettroniche del paziente.
Questa visibilità fornirebbe quindi una conferma oggettiva dei dati raccolti aiutando i membri del team a sentirsi psciologicamente più sicuri.
Una formazione e un'istruzione aggiuntive sull'uso pratico della checklist potrebbero pertanto aiutare a creare un ambiente psicologicamente sicuro e/o potenzialmente rafforzare il valore percepito dello strumento anche quando la sicurezza psicologica è carente. Le prove dimostrano inoltre che i professionisti con uno status gerarchico più elevato segnalano un livello più elevato di sicurezza psicologica.
Quando i membri del team si sentono supportati e rispettati all'interno del loro ambiente di lavoro è più probabile che considerino positivamente i protocolli di sicurezza e ne riconoscano il valore nel promuovere il benessere del paziente. La fiducia nell'efficacia di tali protocolli può essere rafforzata migliorando altresì le dinamiche complessive tra colleghi del team.



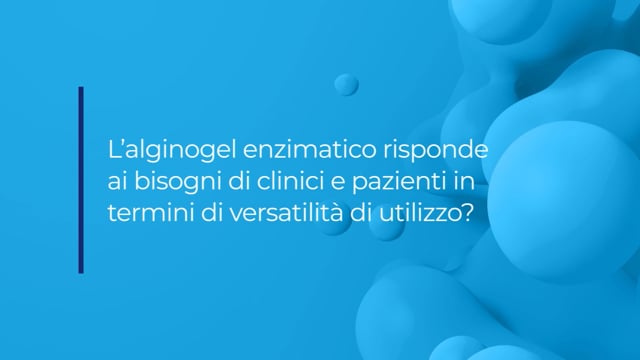














Commento (0)
Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?