Piccole masse di tessuto dalla forma simile a quella di un fagiolo e dalla consistenza duro-elastica, i linfonodi sono dei filtri biologici in grado di intercettare e distruggere germi, cellule neoplastiche e in generale sostanze estranee presenti nella linfa. Sono circa 600 all’interno del corpo e sono presenti in diverse sedi, superficiali e profonde. I linfonodi si trovano raramente isolati nel corpo e tendono, al contrario, a riunirsi in gruppi o catene formando delle stazioni linfonodali che contengono globuli bianchi, in particolare linfociti B e T e i macrofagi. Questa rete è infatti parte integrante del sistema immunitario ed è attiva contro tutte le minacce esterne, contro le quali scatena una reazione immunitaria di difesa. L’ingrossamento dei linfonodi è spesso causato da un attacco all'organismo da parte di batteri, virus, funghi, parassiti e più raramente neoplasie; è infatti l'attivazione e la moltiplicazione dei linfociti a provocare il rigonfiamento dei linfonodi. In genere la linfoadenopatia compare all’improvviso e può essere accompagnata da sintomi come dolore, rossore, prurito e in alcuni casi anche febbre, sudorazioni notturne e perdita di appetito. La diagnosi si pone grazie alla raccolta di dati socio-demografici, anamnesi, esame obiettivo e in alcuni casi esami tra cui quelli del sangue, esami radiodiagnostici e biopsia linfonodale. Il trattamento è direttamente collegato alla causa sottostante e può comprendere terapia antibiotica o antivirale, chemioterapia o radioterapia, asportazione chirurgica del linfonodo etc. Se non trattata, la causa della linfoadenopatia può portare a complicanze come la formazione di ascessi, fistole e sepsi.
Cosa sono i linfonodi e quali sono le loro funzioni

Linfonodo
I linfonodi sono dei filtri biologici o stazioni di controllo, in grado di intercettare e distruggere germi, cellule neoplastiche e in generale sostanze estranee presenti nella linfa. Sono delle piccole masse (da 1 a 25 mm) di tessuto dalla forma simile a quella di un fagiolo e dalla consistenza duro-elastica.
I linfonodi sono costituiti da una capsula fibrosa esterna e da una parte interna divisa in tre zone: corticale, para-corticale e midollare. Sono circa 600 all’interno del corpo e sono presenti in diverse sedi, superficiali e profonde.
Linfonodi superficiali
- Testa (occipitali, preauricolari, sottomandibolari, sottomentonieri)
- Collo
- Sovraclaveari
- Epitrocleari
- Ascellari
- Inguinali
- Poplitei
Linfonodi profondi
- Mediastino
- Addome
- Pelvi
- Retroperitoneo
I linfonodi si trovano raramente isolati nel corpo e tendono, al contrario, a riunirsi in gruppi o catene formando delle stazioni linfonodali o linfocentri che contengono globuli bianchi, in particolare linfociti B e T e i macrofagi. Le principali catene di linfonodi si trovano a livello della testa e del collo, del cavo ascellare, dell’inguine, del torace e della zona addominale.
Linfonodi ingrossati: cosa significa e quali sono le cause
L’ingrossamento dei linfonodi (linfoadenopatia) - che possono raggiungere anche diversi centimetri di grandezza - è spesso causato da un attacco all'organismo da parte di batteri, virus, funghi, parassiti e più raramente neoplasie.
Infatti, se i globuli bianchi riconoscono come estranee le sostanze che invadono i linfonodi, scatenano una reazione immunitaria e, a causa dell'attivazione e della moltiplicazione dei linfociti, i linfonodi vanno incontro a un rigonfiamento.
Nello specifico, tra le possibili cause dell'ingrossamento dei linfonodi troviamo:
|
Faringotonsillite Febbre emorragica crimea-congo Raffreddore Angina da streptococco |
Tumore del pene Tumore dell’ano Tumore dell’uretra Tumore della laringe Metastasi tumorali Sindrome di Sézary Linfogranuloma venereo Paronichia Onfalite |
Balanopostite Antrace Herpes genitale Mastoidite Coccidiomicosi Schistosomiasi Tripanosomiasi africana |
Malattia di Chagas Malattia di Whipple Malattia di Niemann-Pick Sindrome da stanchezza cronica Sindrome da decompressione Punture d’insetto (per una reazione allergica) Rasatura/Ceretta (per un pelo incarnito a causa di uno strappo troppo forte) Ascesso dentale Amiloidosi Reazioni a vaccini (come quello contro morbillo-parotite-rosolia) Farmaci contro l’epilessia Farmaci contro la malaria Farmaci contro la gotta Immunizzazione tifoide |
Sintomi di linfoadenopatia
In genere il rigonfiamento dei linfonodi compare all’improvviso e può essere accompagnato da:
- Ingrandimento che dura per un periodo di tempo prolungato e progredisce rapidamente
- Gonfiore che supera i 4 cm e/o è generalizzato dei linfonodi in tutto il corpo o in alcune regioni linfonodali
- Dolore alla palpazione
- Rossore della pelle attorno al linfonodo
- Calore della pelle attorno al linfonodo
- Noduli duri e non mobili (se la causa del rigonfiamento è tumorale)
- Prurito
- Sudorazioni notturne
- Febbre
- Mal di gola
- Difficoltà a deglutire
- Difficoltà a respirare
- Difficoltà a muovere la testa
- Naso che cola
- Scarso appetito
- Mal di testa
- Stanchezza
- Materiale purulento o di altra natura
- Eruzione cutanea
- Perdita di peso inspiegabile
- Lividi inusuali
- Sanguinamento da naso o bocca
In base alla localizzazione dei sintomi, la linfoadenopatia può essere classificata in:
- Localizzata: quando coinvolge solo uno o pochi linfonodi nella zona intorno alla quale è iniziato il processo infiammatorio. Questa tipologia è quella più comune
- Regionale: quando coinvolge una regione linfonodale che drena una specifica area
- Generalizzata: quando coinvolge in due o più stazioni linfonodali a causa della diffusione dell’infezione tramite il circolo ematico o per un’altra malattia che colpisce l’intero organismo
Inoltre, le linfoadenopatie possono essere distinte in:
- Acute: se sono comparse da meno di 2 settimane
- Subacute: se sono comparse da più di 2 settimane ma meno di 6
- Croniche: quando persistono per più di 6 settimane
Trattamento delle linfoadenopatie
Il trattamento delle linfoadenopatie è direttamente collegato alla causa sottostante. Se si tratta di un virus, il gonfiore si ridurrà non appena l’infezione virale sarà passata, con o senza terapia. Nel caso in cui il rigonfiamento avesse un'origine maligna (tumorale) è importante seguire le indicazioni dello specialista.
Il trattamento può quindi prevedere:
- Terapia antibiotica
- Terapia antivirale
- Chemioterapia
- Radioterapia
- Immunoterapia
- Trapianto di cellule staminali
- Asportazione chirurgica
- Terapia antinfiammatoria e antidolorifica
- Terapia cortisonica
- Impacchi caldi
Potenziali complicanze
Nel caso in cui l’ingrossamento dei linfonodi non viene trattato possono verificarsi diverse complicanze come:
- Ascessi
- Fistole
- Cellulite infettiva
- Linfedema
- Ostruzione intestinale
- Batteriemia: può progredire e diventare una sepsi
Prognosi
Il gonfiore di uno o più linfonodi può tuttavia richiedere settimane o mesi per scomparire. L’impiego tempestivo di antibiotici in genere porta a una completa guarigione.
Prevenzione
Non è possibile prevenire una linfoadenopatia, poiché il gonfiore dei linfonodi è un chiaro segno che il corpo sta combattendo un’infezione o una malattia, di conseguenza è utile ai fini diagnostici e terapeutici.


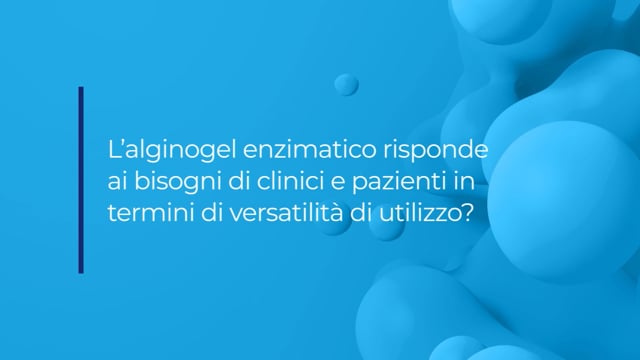














Commento (0)
Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?